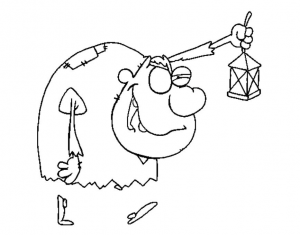Inaugurata dal vice sindaco Letizia Zaffarana, alla presenza di un discreto numero di appassionati d’arte, nel castello dei Principi di Biscari, la mostra intitolata “Un itinerario d’arte attraverso il ‘900”, inserita nel programma del “Settembre a Biscari 2013”. Al tavolo dei lavori Giovanni Bosco di Vittoria, titolare della galleria polifunzionale “Edoné”, che ha sottolineato che la mostra ha come obiettivo di promuovere l’arte nel territorio siciliano e favorire così l’approccio all’arte pittorica, l’assessore alla Cultura, Luigi Denaro, promotore dell’interessante iniziativa culturale, che ha ringraziato i pittori, i relatori e il comitato organizzatore e spiegato le tappe che hanno reso possibile l’evento, lo storico Antonio Cammarana, la scrittrice Maria Teresa Carrubba (pubblichiamo le due relazioni), il critico d’arte Alfredo Campo, che ha presentato i pittori e si è soffermato sul significato delle opere, il vice sindaco Letizia Zaffarana e il presidente del Consiglio comunale, Isaura Amatucci, che hanno messo in evidenza che la straordinaria mostra dà spessore alla cultura e pregio ad Acate.

Il prof. Giovanni Lantino ha coordinato i lavori. Il percorso artistico della mostra comprende il Futurismo, il Pixeling, l’Arte Figurativa, la Transavaguardia, l’Arte Informale, l’Arte Povera e lo Spazialismo con le opere di Lucio Fontana, Piero Dorazio, Antonio Corpora, Mino Maccaniri, Salvatore Fiume, Remo Brindisi, Alberto Sughi, Remo Vespignani, Giuseppe Migneco, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, Emilio Vedova, Giulio Turcato, Mauro Reggiani, Mario Schifano, Franco Angeli, Ugo Nespolo, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Mimmo Germanà, Tano Festa, Felice Casorati, Fausto Pirandello, Antonio Bueno, Fiorenzo Tomea, Antonio Nunziante, Fabrizio Clerici, Jean Calogero, Giulio D’Anna, Pippo Rizzo, Fortunato Depero, Marianna Sallemi, Federica Meli e degli artisti iblei Arturo Barbante, Vincenzo Napolitano, Maurizio Cugnata, Francesco Iacono e Gino Baglieri. Le numerose opere della mostra potranno essere visitate dal 4 al 13 ottobre, dalle ore 18 alle ore 22 nei giorni feriali, e dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 22 nel giorno di domenica.
Redazione (Acateweb)
Il Novecento: un itinerario storico, di Antonio Cammarana
Non è semplice indicare sinteticamente i tratti dominanti ed essenziali del Novecento, anche perché parliamo di una Storia non completamente sistematizzata e ancora soggetta ad una pluralità di contrastanti interpretazioni.
Alcuni storici definiscono il Novecento “secolo delle ideologie”, altri “secolo delle avanguardie”, altri ancora “secolo della tecnologia”. Definizioni che, assieme alle altre, confluiscono, secondo me, nella rappresentazione del Novecento come Apogeo e Simbolo della Modernità.

Il Novecento si apre con “un segnale telegrafico, la lettera S, tre punti nell’Alfabeto Morse”, che, per la prima volta, ad opera dello scienziato italiano Guglielmo Marconi, attraversa l’Oceano, “viaggiando nell’etere, e non lungo un cavo sottomarino, alla velocità
di 300.000 chilometri al secondo, cioè alla velocità della luce”, gettando le basi per la grande rivoluzione delle comunicazioni transatlantiche a beneficio dell’Umanità, tanto da meritarsi nel 1909 il Premio Nobel per la Fisica.
Si afferma il fascino della velocità, di cui è simbolo l’automobile, che è venuto ad appagare il bisogno di emozione, di avventura, di rischio, secondo il proclama del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, apparso a Parigi nel 1909 nel quotidiano “Le Figaro”.
Dal nuovo mondo arriva una grande forma artistica d’Avanguardia, il Cinema, considerato “la decima Musa, che, a differenza delle sue sorelle della mitologia greca, non abita sul monte Elicona, ma in un regno tutto suo, chiamato Hollywood”, la cui figura più grande è quella di Charlie Chaplin, che ci darà due pellicole di rara bellezza: “Tempi moderni” nel 1936 e il “Grande Dittatore” nel 1940.
Nel 1914 e nel 1939 l’Europa precipita, per ben due volte, nella catastrofe della guerra, che vede prima una Germania guglielmina e imperiale, poi una Germania hitleriana e nazionalsocialista impegnata in quello che è stato chiamato “l’Assalto al potere mondiale”( Fritz Fischer,1961).
Sia nella prima come nella seconda guerra mondiale, l’umanità è stata vicinissima alla distruzione universale, ha visto i campi di sterminio e l’Olocausto, la figura più tragica inquietante e criminale del Novecento, portando milioni di esseri umani ad affermare: “Ad Auschwitz Dio non c’era!”.
Ad Auschwitz Dio non c’era, ma non c’era nemmeno ad Hiroshima e a Nagashaki, soprattutto non c’era nella mente di quei fisici nucleari americani che, a Los Alamos, nel deserto del Nuovo Messico, guidati dal fisico Robert Hoppenheimer, direttore dei laboratori atomici, fecero la bomba atomica e la consegnarono al Presidente americano Truman per scopi militari.
Leonardo Sciascia, nel saggio “La scomparsa di Majorana”, afferma che si comportarono da uomini liberi, e furono uomini liberi, gli scienziati tedeschi che con Werner Heisemberg non fecero l’atomica, perché ne intravidero gli effetti catastrofici per l’umanità e
ne ebbero preoccupazione, paura, angoscia. E, secondo me, furono filosofi, filosofi della vita, anziché essere scienziati, scienziati della morte.
Si comportarono da schiavi, e furono schiavi, gli scienziati americani che proposero l’atomica, vi lavorarono, la consegnarono al Presidente Truman, che ordinò di farla cadere in due città del Giappone accuratamente e scientificamente scelte per poterne valutare gli effetti distruttivi: “che l’obiettivo fosse una zona del raggio di un miglio e di dense costruzioni; che ci fosse un’alta percentuale di edifici in legno; che non avesse, fino a quel momento, subito bombardamenti, in modo da potere accertare con la massima precisione gli effetti di quello che sarebbe stato l’unico e il definitivo”.
Nel 1941, Renato Guttuso, pittore dal forte impegno sociale, dipinge “Crocifissione”, in cui rappresenta, non solo la crocifissione di Cristo, ma la crocifissione di tutta l’umanità, resa martire dalla guerra.
L'”Osservatore romano” e il Vaticano considerano Renato Guttuso “pictor diabolicus” (pittore diabolico, pittore del diavolo) e condannano il dipinto giudicandolo eretico soprattutto per la presenza della figura della Maddalena nuda e lo propongono per la messa all’Indice dei Libri e delle Opere proibite dal Tribunale del Sant’Uffizio.
Nel 1945 l’umanità si salva dalla rovina della guerra, ma assiste impotente, alla divisione del mondo nei due blocchi contrapposti del Capitalismo e del Comunismo e al sorgere di quella realtà, che è stata chiamata “la guerra fredda” tra Stati Uniti e Unione Sovietica: uno “status” di forte competizione e confronto tra le più grandi nazioni del mondo che si scontrano, si attaccano, si danneggiano con ogni mezzo, politico economico propagandistico, escluso il mezzo militare.
Nel 1947 l’India, la “perla dell’Impero britannico”, ottiene l’Indipendenza dal dominio coloniale inglese, sotto la guida spirituale di Gandhi, chiamato il Mahatma, la “grande anima”, che propugna i grandi temi della non violenza e del pacifismo.
A Gandhi si ispira Martin Luther King, il “redentore dalla faccia nera”, per l’affermazione della parità dei diritti civili tra Bianchi e Neri negli Stati Uniti. Indimenticabile il suo discorso più famoso pronunciato nel 1963 al Lincoln Memorial di Washington, che incomincia con le parole ” I have a dream” -“Io ho un sogno: che un giorno questa Nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali”. Nel 1964 gli fu assegnato il Premio Nobel per la Pace.
A Ghandi si ispira anche Nelson Mandela, uno dei più prestigiosi uomini politici africani, guadagnandosi, nel 1993, il Premio Nobel per la Pace per aver posto fine all’odioso regime dell’Apartheid, nel Sudafrica.
“Nel 1955 si ebbe la conferma che un nuovo mondo – il Terzo Mondo – era nato e si poneva come Terza Grande Forza accanto al blocco statunitense e al blocco sovietico.
I rappresentanti di 29 Paesi africani e asiatici, che avevano ottenuto l’Indipendenza, si incontrarono a Bandung, in Indonesia, e proclamarono la fine di ogni forma di colonialismo, dell’arretratezza e del sottosviluppo, soprattutto il rifiuto di schierarsi con gli Stati Uniti o con l’Unione Sovietica. Nascevano in questo modo, i Paesi Non Allineati”.
Nel 1963 muore Giovanni XXIII, “il Papa buono”, il Papa che, con il suo linguaggio semplice e diretto, si era rivolto a tutti gli uomini di buona volontà e aveva affermato la centralità dell’uomo nel mondo: “Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e doveri che sono universali, inviolabili, ineliminabili”.
Nella seconda metà del Novecento vive combatte e muore Ernesto Guevara de la Serna, conosciuto come Che Guevara, o semplicemente il Che. Diventato per milioni di intellettuali di studenti di lavoratori il Mito per eccellenza della difesa dei poveri e degli oppressi, della rivoluzione e della guerriglia del XX secolo, davanti al quale si inchinano tutti coloro che hanno vissuto, di persona e non a parole, la” Battaglia delle idee”, nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, nelle Università, in tutti i luoghi di lavoro.
Nel 1968 dai Campus delle Università americane arriva in Europa e in Italia il “Vento della contestazione”, che sfocia nell’occupazione delle facoltà universitarie da parte degli studenti in lotta, che rifiutano di subire le varie forme del potere come dominio di pochi privilegiati, concetto sintetizzato dal “Time” con queste parole:” Il rasoio che ha separato per sempre il passato dal presente”.
Tutti i partiti politici – dalla Destra alla Sinistra – furono colti di sorpresa, nessun partito politico – dalla Destra alla Sinistra – capì che cosa spingeva un’intera generazione di studenti universitari e degli istituti superiori a mettere a rischio il loro futuro e la loro incolumità personale.
Mentre continua, negli Anni Ottanta, la contrapposizione tra le due Superpotenze si afferma, in ogni campo, “anche in quelli che nulla hanno a che fare con le Arti”, il Postmoderno, non tanto come nuovo movimento quanto come negazione di tutti i principi, i valori, i giudizi, che erano stati propri del Moderno, avendo in comune uno Scetticismo Essenziale, un Relativismo Radicale, un Nichilismo Assoluto, che erano stati portati avanti soprattutto da Federico Nietzsche e da Martin Heidegger.
Alla caduta del Muro di Berlino, nel 1989, alla riunificazione della Germania, alla dissoluzione del Comunismo in Unione Sovietica e nei Paesi del Patto di Varsavia, alla fine della “guerra fredda” hanno contribuito in modo determinante Michail Gorbaciov e Papa Giovanni Paolo II. L’uno propugnatore dei processi di riforma legati alla perestrojka (rinnovamento) e alla Glasnost (trasparenza); l’altro, gigante della Chiesa Cattolica, con la sua instancabile azione politica e diplomatica, in campo internazionale. Questi grandi avvenimenti di fine secolo hanno dato agli Stati Uniti, per almeno un decennio, la coscienza di potere essere, nel campo militare, “l’Impero planetario”; primato che, sul piano economico, è stato messo in discussione dall’irruzione, nei mercati internazionali, della Cina e dell’India, che contano la metà della popolazione mondiale. Anche se la scienza e la tecnica ci hanno fatto guardare la terra dalla luna, si continua a non accorgersi delle sofferenze fisiche e spirituali di tanta parte dell’umanità, che, per tutta la sua lunga vita, ha cercato di alleviare quella che è considerata l’EMBLEMA del secolo che si è chiuso: Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la Pace nel 1979, che, dall’alto della sua grandezza, ha voluto considerarsi sempre una PICCOLA MATITA nelle mani di Dio.
Sembra ieri, invece sono passati anni, decenni dall’inizio del Novecento, secolo di guerre, di distruzioni, di olocausti, come pure d’invenzioni, di conquiste, di risorse; secolo che si è chiuso lasciando aperti tanti problemi, che rimarranno sempre irrisolti se si continuerà ad ignorare che tutto nel mondo parte dall’uomo, fa riferimento all’uomo, ritorna all’uomo in modo positivo o negativo, nel bene o nel male.
Antonio Cammarana
____________________________________________
IL XX SECOLO nell’arte, di Maria Teresa Carrubba
Prima di ammirare i dipinti di questo meraviglioso percorso artistico ritengo sia necessario e indispensabile conoscere tutto ciò a cui i loro autori si sono ispirati. A volte ci si chiede cosa si può trovare di interessante nelle opere d’arte di questo magnifico itinerario oltre al bello artistico?
Vi si trova la storia, la vita, i sentimenti dell’uomo, dell’artista che vive il suo tempo. Vi si trova la giusta dose di ironia intelligente che sorregge il tema dei quadri, capace di congelare in una sola immagine LE NOTIZIE DELLE QUOTIDIANITA’.
Si raccontano attraverso la pittura le tappe fondamentali del cammino dell’umanità in un secolo, il novecento, fatto di contraddizioni e perciò complesso e tanto articolato.

Il sogno dell’Italia unita, la pace rincorsa da una grande schiera di uomini travagliati da una crisi profonda, fu un miraggio per chi visse in un secolo segnato da due guerre, e avvertì dentro di se forte il peso di una società ingiusta e crudele.
La condizione dell’individuo sviluppò una coscienza che dava l’amara constatazione dell’assurdità della vita e dell’impossibilità di cambiarla. Spesso non vi si riusciva a trovare la connessione di una vita sociale, della comunicazione con gli altri; contemporaneamente si avvertiva l’impossibilità di sfuggire alle convenzioni, in quanto fuori da esse la vita diventava impossibile.
L’uomo comune, ma anche e ancor più l’intellettuale e l’artista, si sentiva assalito da sentimenti contrastanti, a volte avvertiva l’instabilità della propria condizione, a volte alimentava la voglia di esaltare quotidianamente la vita, a volte diffondeva nella coscienza il sapore amaro della solitudine e dell’alienazione. Essi, tutti quanti, subivano fatalmente la realtà, ma ognuno da quella realtà traeva fuori una sua verità, del tutto soggettiva e quindi diversa da quella degli altri. Molti, come i futuristi, maturarono una coscienza ribelle, un’esasperazione dell’animo, provocate da un forte senso di delusione che serpeggiò e dilagò rapidamente.
Ci si sentiva proiettati in situazioni nelle quali la linea di confine tra il sacrificio e la crudeltà era sottilissima. Posto ogni momento davanti alla necessità di dover scegliere se subire la morte o procurarla, l’uomo avvertì l’incertezza del proprio destino. La coscienza appariva insofferente a lasciarsi sottomettere da qualsiasi schema razionale, appariva angosciata e rifiutava la vita così come gli si prospettava. Per venire fuori da questo stato di cose, alcuni decisero di prendere in mano la propria sorte, di vivere fuori dalla banalità della vita comune, come gli esistenzialisti. Si andò spesso alla ricerca di una propria verità da trovare in se stesso, legata alla propria vita in particolare. Vi furono anche quelli che rivendicavano una vita fortemente individualista, rifugiandosi magari nella natura che offriva quiete e tranquillità, ritenuta l’unica capace di rasserenare gli animi angosciati.
Tra l’artista e la natura si stabiliva talvolta un’intesa perfetta, perché dal contatto e dall’osservazione di essa si traeva l’ispirazione per rappresentarla. Ma l’arte del novecento non consisteva in questo o quel tema, non aveva un motivo dominante come quella del secolo precedente, essa stava in una contrapposizione di temi, in un mobile gioco in cui la caratteristica era l’instabilità di ogni singola unità e la somma di tanti motivi. Accanto alla perpetua ricerca di un riparo riaffiorava sempre l’aspirazione all’eterna evasione da esso, al desiderio di spazi limitati e quieti si contrapponeva l’improvvisa nostalgia di vasti e diversi orizzonti, alla ricerca del tempo perduto faceva da contrasto l’infanzia ritrovata, il desiderio di una vita reale. In questa mobilissima concatenazione di contrasti, dal rifugio all’evasione, è da cercare forse l’autenticità di quest’arte fatta appunto da un continuo passaggio di temi. La maggior parte degli artisti nascevano da una crisi che portava a vedere il mondo senza significato, la loro arte manifestava una negazione estrema, un’ estrema decisione che riempiva di significato metafisico i particolari più semplici e comuni come la rappresentazione di povere creature o grandi simboli o immagini scarne e immediate, colte isolatamente. All’arte del XX° secolo si chiedeva tutto: ragioni di vita e di fede, dimenticanza e consolazione, l’orgoglio di stare solo e la forza di amare, la fiducia nell’azione al di là di ogni limite, lasciando aperto all’ispirazione tutto il sentire dell’animo.
Contro la vanità del mondo restava l’esaltazione dell’arte, ed ecco che lo scacco, il limite umano veniva esteso a tutto fuorché all’arte. Sosteneva D’Annunzio “Il mondo non è del vano conquistatore, ma dell’artefice solitario, il mondo non fu creato se non per essere convertito dall’arte in forme sovrane e immortali”. E poi accanto alla storia che faceva il suo corso camminavano gli uomini del secondo novecento, arrivarono gli anni sessanta carichi di ventate rivoluzionarie, del pluralismo, delle grandi svolte. Gli anni degli intrecci tra gli Stati Uniti, i poteri locali. Il tempo triste e buio della guerra era ormai lontano, ma c’era ancora chi nascondeva i suoi pensieri, i suoi segreti nel dipingere. La luce delle opere create, ancora il loro valore artistico rivelava la realtà interiore vissuta e rivissuta intensamente, ancora si metteva in luce nei volti dipinti la realtà di tutti i giorni, ma anche la dolcezza del temperamento.
L’artista della seconda metà del secolo in questione era antieroe per eccellenza, sempre povero, ma carico di ideali. In questo contesto incontriamo i “quattro grandi siciliani”, Guttuso, Fiume, Mignego e Caruso. Gli italiani vanno dove li porta il loro realismo, e i siciliani tanto di più, unici nella loro insularità psicologica prima che geografica. La loro arte è fatta di volti scomposti, patetici, sereni. Alcuni sono riflessivi, altri concettuali, immagini esilaranti, in cui vi si può leggere anche la follia quasi ordinaria della vita nei manicomi.
Sono tesori, un vero e proprio viaggio nel mondo e nella società di cui sono il frutto, sono esigenza di tutte le persone che vivono in un tessuto sociale come il nostro appunto che fa parte di un popolo la cui storia è così antica, così bella, ma anche dolorosa. L’arte dunque come medicina che curi l’apatia dell’uomo vittima della politica e dei fatti storici. Un’arte che fa riflettere e lascia in bocca un retrogusto persistente, il retrogusto della verità.
Maria Teresa Carrubba